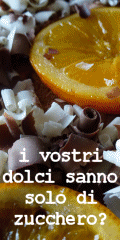L’architettura islamica tra tradizione e innovazione
Dicembre 11, 2002 in il Traspiratore da Redazione
 “Ipotizzare un corso, o più corsi, che abbiano come oggetto lo sviluppo dell’architettura islamica vuol dire aprire le università a temi più vasti, non etnocentrici, più sensibili ad una comprensione di culture, e non solo architettoniche, diverse, ma non per questo estranee al nostro mondo, al nostro passato e al nostro presente” ha affermato la prof.ssa Comneno, docente di archeologia e storia dell’arte islamica presso la scuola di specializzazione in archeologia dell’Università della Basilicata. L’ambito? Il convegno “Ambiente costruito nella cultura islamica”, tenutosi il 21 ottobre 2002 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, simposio cui hanno partecipato numerosi docenti di architettura e di archeologia, molti dei quali di fama internazionale, dal prof. Eugenio Galdieri, premio Agha Khan 1978, allo scrittore Khaled Fouad Allam del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Trieste. Studi e presentazioni incentrate sull’architettura islamica, sui progetti di restauro e di conservazione hanno delineato il filo conduttore: evidenziare “la crisi” di progetto esistente, e quindi non soltanto nell’architettura islamica, per valutarne i motivi principali di degrado qualitativo, individuabili, secondo il prof. Galdieri, nell’attuale irrazionale appiattimento, meramente formale, sui modelli occidentali.
“Ipotizzare un corso, o più corsi, che abbiano come oggetto lo sviluppo dell’architettura islamica vuol dire aprire le università a temi più vasti, non etnocentrici, più sensibili ad una comprensione di culture, e non solo architettoniche, diverse, ma non per questo estranee al nostro mondo, al nostro passato e al nostro presente” ha affermato la prof.ssa Comneno, docente di archeologia e storia dell’arte islamica presso la scuola di specializzazione in archeologia dell’Università della Basilicata. L’ambito? Il convegno “Ambiente costruito nella cultura islamica”, tenutosi il 21 ottobre 2002 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, simposio cui hanno partecipato numerosi docenti di architettura e di archeologia, molti dei quali di fama internazionale, dal prof. Eugenio Galdieri, premio Agha Khan 1978, allo scrittore Khaled Fouad Allam del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Trieste. Studi e presentazioni incentrate sull’architettura islamica, sui progetti di restauro e di conservazione hanno delineato il filo conduttore: evidenziare “la crisi” di progetto esistente, e quindi non soltanto nell’architettura islamica, per valutarne i motivi principali di degrado qualitativo, individuabili, secondo il prof. Galdieri, nell’attuale irrazionale appiattimento, meramente formale, sui modelli occidentali.
Come è ben noto, l’architettura islamica si ispirò alle tradizioni degli Arabi preislamici per dar vita alle sue prime creazioni più di dodici secoli fa. Con l’avvento della dinastia Abbaside (750) e lo spostamento della capitale califfale dalla Siria alla Mesopotamia (Baghdad), si orientalizzò adottando numerose tradizioni artistiche irano-mesopotamiche, cui si aggiunsero, per le infiltrazioni dei turchi nella guardia dei sovrani, numerosi apporti centro-asiatici. Nell’area siro-egiziana l’indebolimento del potere califfale Abbaside permise il formarsi di successive dinastie (Tulunidi, Fatimiti, Ayyubidi, Mamelucchi), che elaborarono un’architettura caratteristica, nella quale venivano messi in evidenza e rielaborati in maniera originale i suggerimenti della tradizione ellenistica della Siria. Nella zona della Sicilia invece si sviluppò lo stile arabo-normanno e nella zona nord dell’Africa e nell’Andalusia si elaborò un’architettura caratteristica, dovuta alla forte tradizione classica e al sostrato indigeno, in particolare berbero. In queste ultime regioni infatti, nacque il cosiddetto stile moresco che caratterizzò nei sec. XIII e XIV la fase classica dell’arte musulmana d’Occidente, culminando poi con le realizzazioni dei Nasridi di Granada: i fastosissimi palazzi dell’Alhambra appunto, la grande Moschea di Cordoba e altre creazioni di quegli architetti che, oltre ad aver capito la città, erano il motore del suo fermento intellettuale. Non a caso, Carlo I di Spagna, visitando, nel 1526, la moschea trasformata in chiesa dopo la caduta di Cordoba, rimproverò i suoi sacerdoti dicendo: “Avete costruito quello che si può vedere ovunque e distrutto ciò che è unico”.
Lungo i secoli, i costruttori islamici acquisirono un’indiscutibile abilità nell’uso e nella disposizione dello spazio interno. Il tema dell’interiorità infatti, dove la parte cava dell’edificio diventa il luogo dell’ombra e della luce, custode di ogni significato reale e simbolico, il grembo dell’ultima verità, era per loro centrale. Essi fecero proprio inoltre il concetto di simmetria, richiamo subliminale a meccanismi evolutivi e percettivi antichi e complessi, all’attrazione esercitata sull’essere umano da motivi e forme periodiche e ripetitive, intendendolo come mezzo per organizzare lo spazio interno, il patio e l’ambiente. La civiltà islamica, civiltà della matematica, della geometria, della medicina, di quella che ancora oggi è la base della cultura, anche occidentale, era riuscita a riprodurre – con relazioni simmetriche di forme geometriche – la perfezione matematica che solo Dio sa costruire e in cui solo Dio sa muoversi e ad esprimere nell’astrattismo di una decorazione geometrica o, spesso, calligrafica un simbolismo di impronta metafisica. Non a caso il matematico Escher, profondamente influenzato dalle sue visite all’Alhambra, studiò e riprodusse molti dei motivi decorativi di quelle sale, arricchendo e maturando il suo linguaggio grafico e traendone ispirazione per i suoi studi sulla divisione regolare del piano e su tutte le possibili simmetrie dello spazio. È dopo queste visite, infatti, che egli realizzò una serie di opere in cui il piano appare interamente coperto da motivi grafici complessi ed affascinanti, incastrati e ripetuti all’infinito, visualizzazione di regole geometriche e matematiche, di concetti astratti estremamente sofisticati che il suo genio percettivo aveva colto nel ritmico groviglio del decoro islamico, dove il linguaggio religioso si sovrapponeva a quello architettonico.
Coloro, come Escher, che non possono leggere lo scritto infatti possono soltanto intuire il significato potente che esso genera assieme alle decorazioni floreali e geometriche su una struttura costruita. E’ inevitabile che la complessa simbologia dell’insieme sfugga in gran parte al visitatore moderno, sopraffatto dalla ridondanza dei cromatismi e dei motivi decorativi, dalla fantastica complessità delle strutture. Non è facile, infatti, capire ciò che sta alla base dell’architettura islamica, espressione di una civiltà fondata su una religione diversa dal Cristianesimo e dalla quale deriva una diversa estetica ed una diversa maniera di intendere l’architettura: il concetto assoluto di una verità trascendente, mistica, inavvicinabile se non attraverso il totale annullamento di ogni individualismo ed ogni singolarità.
di S. El Sebaie